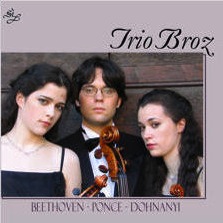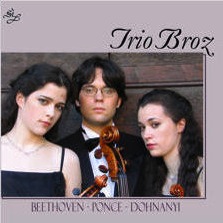 |
Ludwig van
Beethoven: String Trio Op.9 n.1
Manuel Maria Ponce: Trio para violin, viola
y violoncelo
world
premiére recording
Ernst von Dohnanyi: Serenade Op.10
Label:
Sound Image (2004) |
|
  
|
time:
60'45'' - tracks: 1-13
booklet languages: Italiano /
English / Deutsch
Recording: Casa
Fioroni (Rovereto – TN)
7-8 September 2004
|
 |
I Trii op. 9 per violino viola e
violoncello che lo stesso BEETHOVEN
(1770-1827), nella dedica al suo generoso
mecenate, il conte Johann Georg von
Browne-Camus, definì “la meilleure
de [me] oeuvres”, vennero alla luce fra il
1796 e il 1798 (anno di pubblicazione).
Benché siano stati a lungo
trascurati dai critici e dai concertisti,
Giovanni Carli Ballola (Beethoven, Ed.
Bompiani, Milano, 2001) li considera “i
lavori più intensi e perfetti del
primo Beethoven, assolutamente degni di
stare accanto ai successivi sei Quartetti
[op. 18, 1798-1800], che in molte parti
superano in profondità, maestria e
maturità stilistica”. In effetti
l’autore dimostra la capacità di
sfruttare appieno le qualità
timbriche e sonore dell’organico
prescelto, con l’impiego di una scrittura
polifonica densa in cui armonia e melodia
si fondono mirabilmente. Seppur
contraddistinti l’uno dall’altro per il
differente carattere espressivo, i tre
lavori sono strettamente collegati fra
loro da una costante, organica
modalità compositiva, oltre che da
un amabile gusto per l’impasto coloristico
ed una vivacità che riecheggia
anche nei momenti più melanconici
dei tempi lenti. Nel Trio n.1 in Sol
maggiore, si rilevano degli influssi
mozartiani, con particolare riferimento al
Divertimento KV 563 (il lavoro che per la
prima volta, forse, rivelò tutte le
potenzialità dell’organico
violino-viola-violoncello, decisamente
meno sfruttato di altri). Le maggiori
affinità si riscontrano nei due
tempi centrali: l’Adagio, in cui da
melodia distesa ed al contempo introversa
è sostenuta da un’armonia ferma, a
tratti frammentaria, e lo Scherzo che,
curiosamente, presenta la
possibilità di un Secondo Trio. Nel
1924 Schmidt pubblicò questo trio
come possibile aggiunta allo Scherzo sulla
base di un singolo foglio manoscritto
recante l’annotazione autografa “das 2te
Trio muß zum Einlegen geschrieben
werden”. In questo modo il terzo tempo
della composizione presenta la seguente
struttura – analoga al Secondo Minuetto di
Mozart: Scherzo – Trio I – Scherzo variato
(Trio II – Scherzo). Nel primo movimento,
dopo l’Adagio introduttivo, si staglia con
straordinaria forza d’espansione il
meraviglioso tema dell’Allegro con brio,
dove lo sviluppo è condotto con
serio vigore contrappuntistico. Il brano
si conclude con il frenetico Presto
finale, che però concede anche
qualche ulteriore brezza lirica.
MANUEL MARIA PONCE (1886-1948),
compositore messicano, approfondì
la sua formazione musicale in Europa
(1904), studiando pianoforte con Martin
Krause a Berlino, composizione con Marco
Enrico Bossi, Luigi Tocchi e Cesare
Dall’Oglio a Bologna (più tardi,
dal 1929 al 1932, avrebbe avuto modo di
completare la sua formazione con Paul
Dukas, a Parigi). Ritornato in Messico
(1909), divenne docente di pianoforte
presso il Conservatorio Nazionale e
fondò l’Accademia Beethoven che
diresse per anni. Svolse pure
attività di pubblicista e critico
musicale. Per due anni (1915-1917) si
stabilì a Cuba, dove
continuò la sua attività di
insegnante e giornalista. Quando fece
nuovamente ritorno a Città del
Messico, riprese la docenza al
Conservatorio e divenne direttore
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale. La
conoscenza di Andres Segovia fu per Ponce
una circostanza assai proficua che lo
stimolò a realizzare un notevole
corpus di lavori per chitarra. Oltre a
tali brani, il suo catalogo comprende otto
lavori per orchestra, svariate
composizioni cameristiche, un concerto per
violino e uno per pianoforte, pezzi per
organo e per pianoforte solo, più
di duecentocinquanta canzoni e numerosi
corali. La sua produzione, variamente
ispirata al folclore indo-messicano ha
contribuito all’affermarsi del
nazionalismo musicale in Messico, di cui
è considerato il capostipite. Il
Trio para violin, viola y violoncello,
dedicato ai tre fratelli Cecile, Carlos e
Carlitos Prieto, è una composizione
particolarmente esemplare del suo
personale linguaggio musicale, in cui gli
amalgami sonori vengono creati adattando
le regole dell’armonia classica ad un
sistema basato sull’intervallo di quarta.
A livello formale, invece, l’autore si
rifà con serio rigore alla
tradizione musicale europea. Nell’Allegro
non troppo, espressivo si avvale di uno
schema di forma sonata che, senza
risultare scolastica, rispetta i precetti
accademici in tutti i suoi elementi (temi,
proporzioni ed anche rapporti fra
tonalità, – se di tonalità
si può ancora parlare). Le linee
dei tre strumenti si intrecciano con
morbidezza, denotando una concezione
assolutamente cameristica del trio per
archi. Il Minuetto è un gioco a
canone fra violino e viola che poggiano su
un’imitazione contrappuntistica del
violoncello. Per quanto riguarda il
discorso tematico, il compositore tradisce
il suo debito inequivocabile nei confronti
del repertorio popolare ispano-americano,
a lui caro: ne sono un esempio lampante il
terzo tempo, Canción, in cui
è reiterato il languido tema di una
serenata, e la coda del Rondò
finale, in cui i tre strumenti
alternativamente cantano sulle note di una
scala minore napoletana.
ERNST VON DOHNÁNYI (1877-1960)
è considerato, dopo Liszt, il
più celebre pianista ungherese
della storia. Si distinse pure in veste di
direttore d’orchestra e in qualità
di didatta e di responsabile di importanti
organizzazioni musicali. Pur rientrando
cronologicamente nella schiera dei
compositori del XX° secolo, la sua
musica risente marcatamente della
tradizione romantica mitteleuropea, che
egli intese recuperare con tutto il
corredo formale classico, adattato
però alle espansioni di un
personale e intenso lirismo. Soprattutto
l’influsso di Brahms è evidente sin
dal Quintetto op. 1 in Do minore per il
modo di trattare la forma sonata.
Bartók, suo affezionato compagno di
studi, parla di Dohnányi come un
compositore di alta levatura artistica,
anche se non troppo interessato al
repertorio popolare e quindi, in certo
senso, isolato nel contesto delle
cosiddette “scuole nazionali”. La sua
produzione non annovera più di
quarantotto composizioni. La Serenata op.
10, l’unica creazione per trio
strumentale, risale al 1902 e rappresenta
una tappa fondamentale della sua carriera
poiché gli permise di individuare
definitivamente una peculiare cifra
espressiva. Apparentemente in cinque
movimenti, la Serenata è invero
costituita dai quattro tempi classici,
alternati, secondo le consuetudini
settecentesche, nella successione lento -
veloce - lento - veloce, e preceduti da
una introduzione marziale che, collegata
da affinità tematiche alla parte
conclusiva dell’Allegro vivace, funge da
cornice per l’intero lavoro.
Particolarmente interessante risulta
inoltre la tripartizione dei vari tempi
che, se lenti, presentano al loro interno
un episodio più agitato, se veloci,
più disteso. Il secondo tempo,
Romance, contiene uno spiccato lirismo e
rivela una particolare cura nel dispiegare
il discorso melodico nel registro
più efficace dei tre strumenti.
Dopo il virtuosistico Scherzo, compare un
duplice atto d’omaggio al classicismo
viennese: Tema con variazioni, dove il
materiale tematico è elaborato con
estrema duttilità e introduce
soluzioni armoniche inattese, e Finale, in
forma di rondò.
Francesco
Bissoli
|
|
|



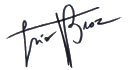 Solo sul presente sito è possibile
l'acquisto del CD con autografo e dedica originale del
Trio. Cliccare
qui per andare alla pagina acquisti.
Solo sul presente sito è possibile
l'acquisto del CD con autografo e dedica originale del
Trio. Cliccare
qui per andare alla pagina acquisti.