 |
Divertimento
NUOVO!
W.A.Mozart: Divertimento KV563
F.X.Süssmayr: Trio in D - world première recording
Label: Universal (2011)
|
|
Nel 220° anniversario della morte di Mozart,
l'omaggio del Trio Broz al grande Compositore,
affiancato dalla prima incisione mondiale del Trio
scritto negli stessi anni
dall'allievo, amico e consulente Süssmayr.
time:
54'57"
booklet languages: Italiano / English /
Deutsch
HD HIGHT DEFINITION RECORDING AND
MASTERING, 24 bit 96 kHz
Recording: Sala
San Giuseppe (Rovereto – TN)
August 2010
|
 |
"C’è una sorta d’ingombrante
presenza esterna che unisce il
Divertimento (Trio) in Mi bemolle per
archi di Mozart (ultimo di una serie di
analoghe composizioni per violino, viola
e violoncello) e l’omologo (ma unico)
Trio in Re di Franz Xaver Süssmayr:
l’incompiuto Requiem in Re minore. Sia
perché, come tutti sanno, la
sopravvivenza della figura storica e
artistica di Süssmayr è
ineluttabilmente legata al completamento
della partitura; sia perché il
lavoro mozartiano nacque nell’autunno
del 1788 per l’amico e fratello massone
Johann Michael Puchberg, destinatario
delle più pressanti (e accolte)
richieste di denaro: «Il conte
Hadik mi ha invitato per venerdì
mattina a fargli ascoltare il Trio che
ho scritto per voi», gli scrisse
Mozart l’8 aprile 1790, riferendosi al
Divertimento. Ma Puchberg fu anche uno
dei comprimari delle tortuose vicende
che accompagnarono la committenza della
messa per i defunti. Il mercante aveva
bottega e abitazione nel Palazzo del
conte Franz Anton Walsegg zu Stuppach
nella zona di Wiener Neustadt: in
virtù dei crediti contratti col
compositore, non ebbe difficoltà
a farsi da portavoce con Mozart della
richiesta dell’aristocratico di
provincia che voleva associare
un’inoffensiva vanità - pagare
musicisti per scrivere lavori che
ricopiava e faceva eseguire come suoi -
al desiderio di celebrare la recente
scomparsa della giovane moglie.
Certamente Walsegg non avrebbero mai
voluto entrare nella storia per la sua
ingenua (e permessa, in regime anteriore
al diritto d’autore) eccentricità
musicale.
Null’altro,
se
non la singolare vicinanza tra data di
pubblicazione postuma del primo e
presumibile periodo di gestazione del
secondo, le avvicina: le composizioni
sembrano appartenere a secoli diversi. La
responsabilità maggiore è di
Mozart che in questo lavoro, nato in una
stagione di fervore creativo e di successi
(la prima viennese di Don Giovanni) ma
anche di scelte dal sapore testamentario -
come la determinazione nel concludere la
serie delle Sinfonie (la Jupiter è
del 10 agosto) e, quasi, dei Concerti per
pianoforte (il Krönungskonzert di
febbraio) - si esprime con maturità
e modernità di pensiero
inversamente proporzionali all’organico.
Il
Divertimento
fu la terza composizione cameristica
scritta in pochi mesi per Puchberg, cui
erano stati intitolati i Trii con
pianoforte K 542 e 548. Anche in questo
caso, la dedicatoria non fu disinteressata
«Sono libero d’invitarvi: lo
suonerà Häring. Sarei venuto
personalmente per parlarvene a voce ma i
dolori reumatici alla testa mi rendono
intrattabile» - scrisse ancora nella
comunicazione dell’8 aprile -
«ancora una volta vi prego di
aiutarmi secondo la vostra
disponibilità e di per-donare la
mia insistenza». In primo tempo
Mozart aveva iniziato un altro Trio
pianistico (in Sol maggiore) poi scelse di
riaprire i conti con un genere più
volte praticato in gioventù..."
Angelo
Foletto
|
|
 |
Gli strumenti
Per questa registrazione il Trio Broz
ha suonato su un particolare trio di
strumenti:
Violin Giuseppe Antonio
Rocca, Torino, 1839
Viola, scuola milanese,
secondo quarto del XVIII secolo
Violoncello Louis Guersan,
Parigi, 1743
Violino
Giuseppe
Antonio
Rocca, Torino, 1839
Le prime
testimonianze pervenuteci,
inerenti alla vita professionale
di Giuseppe Antonio Rocca
(Barbaresco 1807 – Genova 1865)
risalgono al 1834, quando venne
assunto come apprendista dalla
rinomata bottega torinese del
celebre liutaio Giovanni Francesco
Pressenda. Qui Rocca diede
immediatamente mostra di possedere
grande talento e spiccata
manualità, imparando
velocemente le tecniche
costruttive dell’arte liutaria.
Anche se alla fine del 1837
lavorava già in una propria
bottega, in modo totalmente
autonomo, continuò a
produrre strumenti in bianco per
il suo maestro fino al 1840 circa.
Fu senza dubbio il miglior
collaboratore di Pressenda e tra
le opere degli autori di spicco
dell’ottocento italiano, quelle di
Rocca sono, oggi, le più
ambite e le più quotate.
Questo violino fa parte di quella
interessante produzione annoverata
fra il 1838 e il 1842 dove i
lavori di Rocca, pur restando
palesemente influenzati dalla
lezione impartitagli dal suo
maestro, vengono elaborati in modo
personale dando vita ad un suo
unico vero stile, lo “stile
Rocca”. Dal 1842 in poi, fino alla
sua morte, Rocca fortemente
influenzato dalle opere dei grandi
classici cremonesi,
imposterà tutta la sua
produzione sui modelli “Messia” di
Antonio Stradivari e Alard di
Giuseppe Guarneri “del
Gesù”. |
 |
Viola,
scuola milanese, secondo quarto
del XVIII secolo
Per quanto concerne
la costruzione della viola in
Italia tra sei e settecento, le
scuole più importanti che
hanno contribuito allo sviluppo e
al perfezionamento di quest’arte,
sono state senza dubbio quella
bresciana e quella milanese.
Questa interessante viola, ridotta
verosimilmente nell’ottocento
nella sua originale misura di
viola tenore, presenta molte
caratteristiche che ci inducono ad
attribuirla alla scuola milanese.
Dal disegno e dall’impostazione
delle “ff” prossime a certi lavori
dei fratelli Testore, alla
particolare rifinitura della
tavola armonica, che ne esalta la
venatura del legno, come
solitamente riscontrabile sulla
maggior parte degli strumenti
milanesi, alla vernice dove
qualità e colore ricordano
le migliori utilizzate da Carlo
Ferdinando e Pietro Antonio
Landolfi. La forza espressiva del
lavoro, eseguito con la massima
cura nella realizzazione dei
dettagli unitamente
all’impeccabile stato di
conservazione fanno, di questo
strumento, un vero
capolavoro.
|
 |
Violoncello
Louis Guersan, Parigi, 1743
Se dovessimo citare
un personaggio capace di
rappresentare la grande liuteria
parigina del settecento, la nostra
scelta ricadrebbe certamente su
Louis Guersan (Parigi 1700 –
1770), il più importante e
conosciuto liutaio della Francia
tardo barocca di Luigi XV. Non
abbiamo notizie certe sulla sua
formazione professionale ma da
recenti ricerche d’archivio si
evince che nel 1725,
all’età di venticinque
anni, amministrava una propria
bottega nel centro di Parigi dove
venivano prodotti e
commerciati strumenti musicali ad
arco. L’entusiasmo scaturito da
un’attività prosperosa
indusse Guersan a ricercare una
nuova e più ampia sede che
ben presto trovò nel
quartiere di St. Germain des
Prés; qui lavorò
fino al 1770, anno della sua
morte. Sotto la sua guida si
formarono liutai di grande rilievo
tra i quali, Benoist Fleury e
François Lejeune. Il
violoncello Guersan datato 1743,
una delle migliori espressioni
artistiche di questo autore, fu
costruito nel periodo di piena
maturità.
Instancabile lavoratore
continuò per tutta la sua
carriera un’intensa ricerca volta
a perfezionare sia il
progetto acustico dei suoi
strumenti sia la formulazione
delle sue splendide vernici stese
solitamente su legnami di
eccellente qualità e
notevole impatto estetico. I suoi
strumenti, conservati in numerosi
musei d’ambito internazionale,
sono sempre più apprezzati
da collezionisti e musicisti.
|
 |
|
|
|







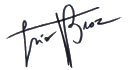 Solo sul presente sito è possibile
l'acquisto del CD con autografo e dedica originale del
Trio. Cliccare
qui per andare alla pagina acquisti.
Solo sul presente sito è possibile
l'acquisto del CD con autografo e dedica originale del
Trio. Cliccare
qui per andare alla pagina acquisti.



